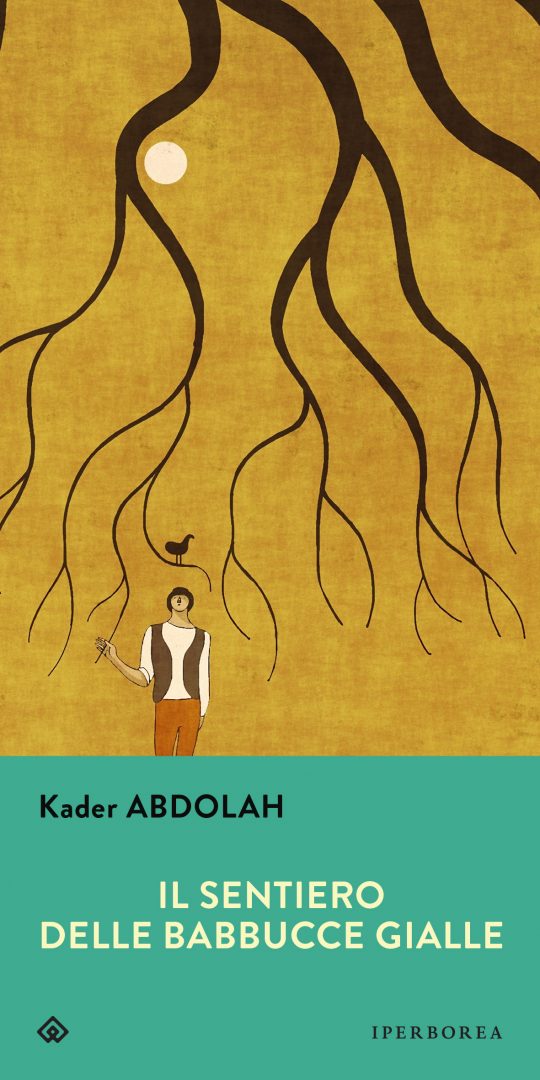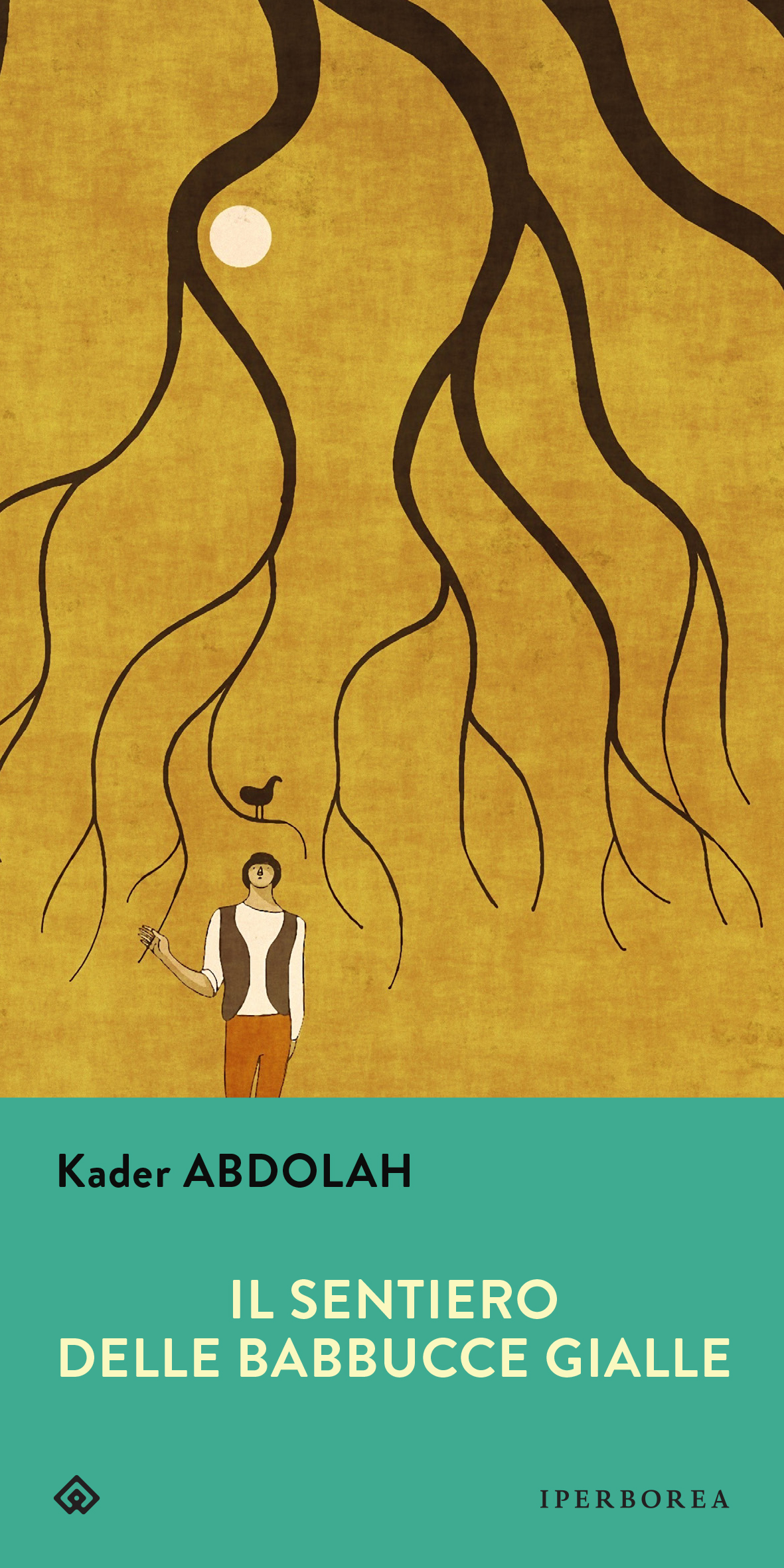“Il giorno volgeva al termine, il sole era appena tramontato. Stavo andando alla moschea a portare un paio di babbucce gialle a una donna che non era mia”.
Un paio di scarpine tradizionali cucite a mano, un gesto d’amore attorno al quale si svolge una narrazione di narrazioni. Una storia di storie incastrate le une nelle altre, come si conviene nelle migliori letterature d’Oriente, quelle concepite al talamo di Shahrazād col solo intento di restare in vita.
Lungo Il sentiero delle babbucce gialle, ultimo romanzo dello scrittore iraniano Kader Abdolah per Iperborea, Oriente e Occidente si intrecciano come nel destino del protagonista, il giovane regista Sultan Golestan Farahangi – alias, il poeta rivoluzionario Saeed Sultanpour, giustiziato nel 1981, alla cui biografia si ispira tutto il romanzo – che dal suo esilio olandese, proprio come l’autore, riavvolge la pellicola del passato.
Ogni tuffo nella memoria personale e familiare corrisponde a un fermoimmagine della storia iraniana, esattamente come Abdolah ci ha abituato nei suoi capolavori precedenti, in modo particolare ne La casa nella moschea (Iperborea, 2008): dall’avvento della dinastia Pahlavi, gli scià responsabili di aver consegnato il Paese all’America, alla rivoluzione (tradita) che il primo febbraio del 1979 portò gli āyatollāh al potere, decretando la nascita della Repubblica Islamica dell’Iran.
Un viaggio sul filo delle parole, quelle di un cineasta divenuto interprete della storia nazionale, che a un certo punto decide di mettere per iscritto le immagini che hanno accompagnato la sua vita. Così le babbucce gialle, al pari delle scarpette rosse di Dorothy nel regno di Oz, diventano l’oggetto totemico grazie al quale intraprendere un viaggio alla ricerca di se stessi.
Ecco che la pellicola di Sultan diviene carta, per posare uno sguardo inedito sulla realtà che lo circonda. A partire da quando, ancora bambino, spiava quella realtà sconosciuta attraverso la lente di un cannocchiale regalatogli dal nonno, dall’alto della torre del castello in cui viveva, al riparo di una famiglia benestante di commercianti di zafferano; passando quindi per la lente di una macchina fotografica arrivata dall’Occidente, collezionando involucri di gomma da masticare…
“Fotografai mia madre mentre andava al laghetto. Fu un’esperienza sorprendente. […] Fu solo in quel momento che mi resi conto che era zoppa e che mio padre creava scarpe apposta per lei. Al fotografo piacque molto un ritratto di mio nonno. «C’è qualcosa di inafferrabile», osservò. Era vero, perché l’avevo fatto mentre mio nonno parlava con il suo jinn. […] Nemmeno gli uccelli conoscevano il potere dell’arte, e volarono sopra il castello stridendo di gioia e di sconcerto.”
…infine, attraverso l’obiettivo della cinepresa, prima a Teheran e poi nell’altrove dell’esilio…
“A un tratto l’epoca di mio nonno e del suo jinn era finita. Un giorno in cui l’uccello Hodhod si mise a volare nervosamente avanti e indietro gracchiando sopra la sua stanza, tutti capirono che ci aveva lasciato. Una settimana dopo il suo funerale feci la valigia e partii. Sapevo che come mio nonno e il suo jinn non avrei mai più fatto ritorno.”
La macchina da presa è ora al servizio della rivoluzione comunista e della lotta di liberazione che, suo malgrado, finirà per consegnare il potere a Khomeini. La voce di Kader Abdolah si conferma, ancora una volta, voce del cantastorie che affabula senza rinunciare a uno sguardo lucido, di verità, capace di smascherare le incongruenze che serpeggiano tra le pieghe della tradizione, del modernismo e del radicalismo.
Un viaggio nel Sé individuale e collettivo, sapientemente intessuto, come nello stile dell’autore, di identità, fiaba, ricordo e visione.